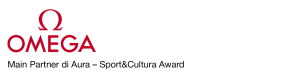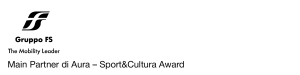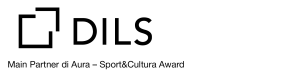Ormai sono passati più di dieci mesi. Ma avrebbero potuto essere dieci anni, dieci minuti o dieci secondi, non sarebbe cambiato nulla. Per lui e per noi. Perché, alla fine, la sensazione è sempre la stessa, uguale e immutabile, che tu sia attore o spettatore. 1 dicembre 2024, stadio Artemio Franchi di Firenze, Fiorentina-Inter, 14′ del primo tempo: mentre la palla è lontana, Edoardo Bove si accascia sul terreno di gioco privo di sensi. Si risveglierà in ospedale qualche ora dopo con il primo pensiero di essersi infortunato al ginocchio e con un vuoto di memoria che verrà colmato dalle parole di amici, familiari e compagni di squadra.
Da allora è come se, per il ragazzo nato e cresciuto (calcisticamente e non) a Roma, si fosse aperta una nuova e imprevista fase della vita, con prospettive molto diverse da quelle immaginate fino al momento prima in cui tutto è diventato nero. Funziona così, ha sempre funzionato così. Se fai il calciatore, hai 22 anni e sei alla tua quinta stagione da professionista, non riesci a vedere oltre la tua dimensione di atleta, non riesci a pensare a quel dopo che sembra comunque sempre troppo lontano nel tempo e nello spazio: ritiri, allenamenti, viaggi, partite, così in loop per almeno una decina d’anni. Non esiste altro, non dovrebbe esistere altro, fino alla soglia dei quaranta.
E, invece, Edoardo Bove con quel dopo ha dovuto iniziare a fare i conti fin da subito, nel modo più duro possibile, un frontale con la realtà che non è semplice da metabolizzare: che sia sul palco del Festival di Sanremo o davanti al microfono del Basement di Gianluca Gazzoli, le parole di Bove testimoniano tutta la difficoltà di un percorso di accettazione e autodeterminazione di sé che non è figlio di una scelta, ma di una circostanza imposta da un destino rivelatosi avverso. Certo, c’è la gratitudine e la consapevolezza di una “seconda possibilità” che non capita a tutti, ma c’è anche un rollercoaster emotivo difficile da sostenere, la convivenza con la sensazione di sentirsi improvvisamente fuori posto ovunque ti trovi, la necessità di trovare al più presto un nuovo posto nel mondo, un nuovo scopo, una nuova identità. Tutto questo è emerso anche nel post su Instagram con cui si è congedato da Firenze, dalla Fiorentina e dai tifosi viola: quando scrive «ci abbiamo provato in tutti i modi»
Bove è come se ci stesse parlando di una feroce lotta interiore – che è ancora in corso e lo sarà fin quando non capirà quali sono i suoi nuovi limiti – tra la voglia di sentirsi ancora il calciatore pronto a prendersi il presente e il futuro e la contemplazione di un domani in cui quello che c’era prima potrebbe non esserci più. In un’epoca in cui i ventenni si confrontano quotidianamente con degli standard di eccellenza imposti da una società che non li capisce mai fino in fondo, la storia di Bove rappresenta una testimonianza vivida e tangibile di come la consapevolezza di sé sia il primo passo per raggiungere qualsiasi obiettivo; e, soprattutto, di come questa consapevolezza non sia un qualcosa di automatico e naturale ma una conquista di ogni giorno, da difendere, custodire e utilizzare nei momenti di sconforto, quando a prendere il sopravvento è la nostalgia di ciò che era stato o, peggio, di quello che poteva essere. Un rischio che per Bove, lo stesso Bove che aveva racontato di essere diventato un centrocampista per assecondare il suo desiderio di stare «al centro del gioco», era più reale che mai.
Oggi quel rischio è stato sepolto da una tenacia e da una dignità che forse nemmeno lui sospettava di possedere. E che vanno oltre la possibilità di poter tornare a essere un calciatore oppure no; quello non conta più, o non conta più così tanto. Edoardo Bove lo ha capito. E, ancora più importante, sta facendo in modo che lo capiscano anche gli altri.