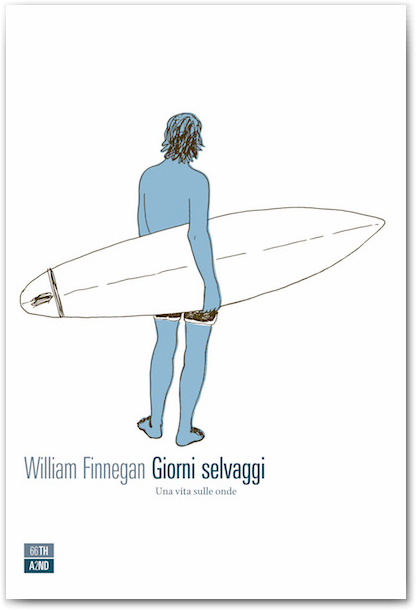Newport mi piaceva, ma San Onofre mi piaceva di più. Si trovava una sessantina di chilometri più a sud, su un lembo di costa selvaggia circondata da una grande base di Marine. I Becket caricavano i bimbi e l’attrezzatura da campeggio sul furgoncino Volkswagen e andavano a passare lì il weekend. San Onofre era uno degli avamposti del surf in California, e gli appassionati che campeggiavano da quelle parti per surfare, pescare e cacciare gli abaloni avevano ottenuto dai militari, non si sa come, il tacito permesso di restare anche dopo che fu costruita la base. Per raggiungere la costa bisognava percorrere una strada sterrata, dove però il transito era bloccato da un corpo di guardia, eppure i membri del Club del surf di San Onofre erano autorizzati a passare. Bill senior era uno dei soci fondatori. La spiaggia non era niente di speciale – stretta e brulla, con il fondale marino roccioso – ma le famiglie che campeggiavano lì condividevano lo spazio a disposizione con una gioia palpabile, senza pretese. Sembravano tutti laureati in divertimento. Tavole da surf, canne da pesca, attrezzatura da snorkeling, vecchi kayak, gommoni gonfiabili – tutte cose per entrare in acqua. I furgoncini con le tende ombreggianti scolorite e le capanne tiki costruite con la legna portata dal mare offrivano riparo dal sole. Dopo il tramonto iniziavano i tornei di bridge e pallavolo, la gente suonava e cantava intorno ai falò, e il martini era la valuta legale.

Poi c’erano le onde. Le onde di San Onofre erano démodé negli anni Sessanta, quando le vidi per la prima volta – troppo lente, troppo morbide. Agli inizi della moderna èra del surf, tuttavia, quando le tavole erano enormi, molto pesanti e di solito non avevano le pinne, puntare dritti alla spiaggia con un minimo di rotazione era la tecnica migliore (se non la sola possibile), e San Onofre offriva forse le onde migliori di tutta la California per questo stile di surf. Le surfate erano lunghe e tranquille, e le scogliere sommerse erano abbastanza varie da mantenerle interessanti. Molti dei surfisti che avevano modernizzato il design delle tavole dopo la Seconda guerra mondiale si erano fatti le ossa a San Onofre – era la Waikiki della West Coast, hotel e baraonda a parte. E rimaneva comunque il posto ideale per imparare a surfare.
L’acqua era limpida, color turchese chiaro, bassa. Ma abbastanza profonda per surfare in tranquillità. Così lo feci, più e più volte, durante quel primo giorno.
È qui che ho cavalcato le mie prime onde, su una tavola verde presa in prestito un giorno d’estate all’età di dieci anni. Non mi pare che ci fosse qualcuno a darmi istruzioni. C’erano anche altre persone in acqua, ma a San Onofre lo spazio è ampio. Ero uscito al largo remando da solo con la testa china, attaccata alla tavola, solcando le linee morbide e argentee della schiuma. Intorno a me, osservavo gli altri surfisti in azione. Li guardavo e cercavo di imitarli. Girai la tavola verso la spiaggia. Le onde non erano niente in confronto a quelle gigantesche che si frangevano sul fondale sabbioso che conoscevo da anni facendo bodysurf. Ma la marea era bassa e il vento leggero, ed era un gioco da ragazzi riconoscere le onde in arrivo. Mi trovai davanti a un muro d’acqua, largo, con la cresta uniforme che si stava sgretolando, e come un folle mi buttai giù. L’accelerazione – mentre la tavola sollevandosi prendeva l’onda – fu meno drammatica e violenta di quanto accadeva sui fondali sabbiosi con il gommone o facendo bodysurf. Ma poi l’emozione, soprattutto il brivido della velocità, di saltellare sulla superficie dell’acqua di fronte all’onda, sembrava non finire più. Quello slancio potente era una sensazione nuova per me. Oscillavo sui piedi. Ricordo di aver guardato da una parte e aver notato che l’onda non si stava esaurendo, poi di aver guardato dall’altra parte e aver visto che la mia traiettoria era quasi tutta libera, e infine di aver guardato in basso rimanendo pietrificato dal fondale roccioso che scorreva sotto i miei piedi. L’acqua era limpida, color turchese chiaro, bassa. Ma abbastanza profonda per surfare in tranquillità. Così lo feci, più e più volte, durante quel primo giorno.

Eppure venivo dall’entroterra, e questo era una macchia indelebile. Woodland Hills, dove vivevamo, si trovava nella parte nord-occidentale della contea di Los Angeles. Era una terra di aride colline – ai piedi delle montagne di Santa Monica – sul confine occidentale della San Fernando Valley, una distesa beige di lotti inquinati. I miei amici che stavano lì tutto l’anno non sapevano niente dell’oceano. Le loro famiglie si erano trasferite a ovest da regioni interne – Pennsylvania, Oklahoma, Utah. I padri lavoravano in ufficio, a parte il papà di Ricky Townsend, Chuck, che aveva una piattaforma petrolifera sulle colline, dalle parti di Santa Paula. Io e Ricky andavamo spesso con lui. Indossava un elmetto rigido, sudicie camicie da lavoro e guanti enormi. La piattaforma era in funzione giorno e notte, pompava e batteva e lui aveva sempre qualcosa da riparare. Immagino che lo scopo fosse trovare un pozzo petrolifero spontaneo, un’improvvisa esplosione di oro nero. Nel frattempo, io e Ricky non avevamo granché da fare. La piattaforma aveva una torre con in cima, fra le travi, una piccola cabina con il pavimento di compensato, e il signor Townsend ci lasciava arrampicare fin lassù per trastullarci con una radio a transistor, ascoltando Vin Scully che commentava le partite dei Dodgers a notte fonda. Koufax e Drysdale erano all’apice della carriera, per i battitori non c’era niente da fare, e noi pensavamo che sarebbe stato sempre così.
Vivevamo sperduti tra le colline. I nostri vicini, come i genitori dei miei compagni delle elementari, sembravano tutti di vedute ristrette – l’atavismo era rinforzato dalla topografia. L’impressione era di essere in un paesino, in un covo di ottusi xenofobi. La John Birch Society era forte. I miei genitori e i loro amici liberal e cosmopoliti rappresentavano una minoranza – sostenitori di Adlai Stevenson in una cittadina schierata per Sam Yorty. (Yorty era il sindaco di Los Angeles, un tenace, sprezzante, rozzo anticomunista originario del Nebraska). I miei genitori sottoscrissero il bollettino di informazioni I.F. Stone’s Weekly e appoggiarono con passione il movimento per i diritti civili. Si batterono contro il provvedimento promosso da un partito locale che permetteva ai proprietari di immobili di discriminare i clienti in base alla razza. «No al 22», diceva il cartello nel nostro giardino. Persero. La scuola elementare di Woodland Hills rimase al 100% bianca.

La cosa migliore delle colline erano le colline. Piene di serpenti a sonagli, vagabondi e coyote. Soprattutto oltre Mulholland Drive, che a quei tempi era ancora una strada sterrata, dove noi ragazzi facevamo lunghe escursioni tra le vecchie riserve di caccia e i ranch di cavalli. Sparsi tra le colline e i canyon c’erano roccaforti e fortini sugli alberi di cui rivendicavamo la proprietà, e combattevamo contro le bande di ragazzi delle altre valli che incontravamo in questa terra di nessuno. All’improvviso le colline digradavano ripide come cascate. E noi ci lanciavamo in picchiata con bici, pezzi di cartone, slittini dalle ruote di gomma («Da un rampicante all’altro, i ragazzi scivolavano alla velocità del fulmine»), e poi, quando cominciarono a diffondersi, con gli skateboard. Perfino le vie lastricate erano ripide fino all’inverosimile. Ybarra Road andava giù a strapiombo, tanto che gli autisti che non la conoscevano, trovandosela davanti, si fermavano, invertivano la marcia e cercavano una strada alternativa.