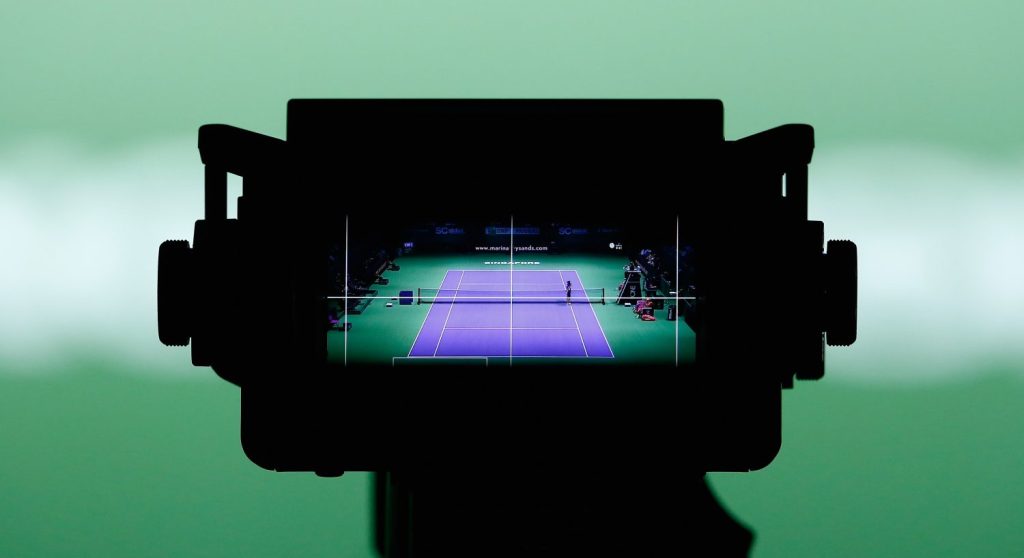I francesi spesso usano la parola relâchement parlando del gioco di Federer. Potremmo tradurla con “rilassatezza”. A mio avviso, la chiave è la sua elasticità: il movimento armonioso, la forza non «forzata», la capacità di escogitare un gioco di prestigio anche sotto pressione. «Se anche gli metti altri dieci chili di muscoli addosso, non è detto che colpirà la palla più forte», mi ha detto il suo ex allenatore José Higueras. «Potrebbe anche colpirla peggio. Non è questione di forza, ma di timing.» Ella Ling, una delle migliori fotografe di tennis, agli inizi non fotografava mai Federer perché tratteneva troppo le emozioni. Poi ha cambiato prospettiva. «Non vedrai mai il suo viso contorcersi quando colpisce la palla. E questo dice tutto», mi ha spiegato. «Per lui giocare a tennis è naturale, non gli costa alcuno sforzo. È un’estensione del suo corpo e della sua mente. È qualcosa di unico, che credo non rivedremo mai più.»
Il suo relâchement lo ha senz’altro aiutato a resistere nel tempo quando tantissimi suoi colleghi si erano già ritirati. Dei 128 tennisti presenti nel torneo di singolare degli Open di Francia 1999, lo Slam in cui Federer ha debuttato, è l’unico ancora attivo nel circuito. «Ma dai!» ha esclamato quando gli ho riportato questa statistica. «Non c’è più nessuno?» Pochissimi tennisti della sua età, o più vecchi, gareggiano ancora in singolare: Feliciano López, il mancino spagnolo che fu suo rivale da juniores; e Ivo Karlović, l’imponente croato dal servizio potentissimo e la barba sale e pepe. Ma la wild card ricevuta a Parigi nel 1999 aveva messo Federer davanti a tutti gli altri, e vent’anni dopo è ancora lì, a lottare per vincere i major e ad accumulare titoli: all’inizio del 2019 aveva vinto il suo centesimo torneo a Dubai e il centunesimo a Miami. Natura o cultura? «Il talento forse mi ha aiutato ad avere la tecnica che ho oggi e che mi permette di logorarmi meno», disse. «Ma penso di essermi guadagnato tutto con la programmazione, l’allenamento e forse la mia mentalità. Per quanto prenda le cose seriamente, sono molto rilassato, e decomprimo in fretta. Questo pranzo, per esempio, è una pausa. Nella mia testa dico: “Ok, ci siamo appena allenati al massimo e adesso posso rilassarmi. Poi torniamo al lavoro”. Penso che la chiave sia un approccio di questo tipo.»
Federer è un’intrigante miscela di ordine e spontaneità, o forse non è una miscela ma qualcosa che funziona più a corrente alternata. È come se grazie alla sua programmazione riuscisse sempre a vivere nel qui e ora, a essere totalmente presente, e inoltre è particolarmente refrattario alle influenze esterne che possono interferire con il suo ciclo naturale. La questione del ritiro aleggia nell’aria dal 2009, eppure, ancora dieci anni dopo, mi disse che non ci aveva pensato nei dettagli. «Sto cercando di essere flessibile, per capire davvero cosa fare», disse. «Quanto tennis? Quanto lavoro? Quanta famiglia? Naturalmente mi piacerebbe tenere aperte tutte le opzioni, innanzitutto per i miei figli e per Mirka. Di sicuro non voglio impegnarmi troppo presto in qualcosa e poi avere dei rimpianti. Quindi non lo so. Non lo so davvero. Ho sempre detto che, se penso troppo al ritiro, vuol dire che mi sono già ritirato. Ho la sensazione che se faccio troppi programmi per il post-carriera, sono già a metà strada, ritirato a metà.» «E questo condizionerebbe le tue prestazioni?» chiesi. «Be’ non la prestazione in sé, ma forse la voglia di fare bene. Penserò a tutto quando mi sarò ritirato. Non ho voglia di stressarmi adesso.» Per anni aveva mandato all’aria i piani che gli altri avevano per lui. «“Sei stato il numero uno del mondo, hai vinto tutti e quattro gli Slam, e adesso? Ormai è finita, no?”», disse facendo il verso alle domande e alle supposizioni. «È sempre stato così.»
Ormai si era accorto che tutti si stavano posizionando sulla linea del traguardo, una cosa che, nel bene e nel male, i giornalisti come me hanno scritto nel DNA. «Devono raccogliere roba extra, per cui sento che la rete mi si sta stringendo intorno», disse. «Tutti chiedono quell’intervista in più, se possono parlare con me. Io rispondo che se proprio devono, ok. Ma va bene. È quel che è. È ok.» Un’altra eredità di Federer è che risparmierà ai futuri campioni lo stesso ripetitivo interrogatorio fino a una fase molto avanzata della loro carriera. «Spero di sì», disse. Poi aggiunse: «Stan ha appena dichiarato che gli piacerebbe giocare qualche altro anno. Ne ha appena compiuti trentaquattro, e a trentaquattro anni una volta si era vecchi, e adesso invece puoi sperare di giocare altri tre, quattro, cinque anni». Alzò la voce e agitò le mani. «Insomma, fra cinque anni sono trentanove!» disse. «Ma è dura, perché i migliori sono forti.»

Federer non ha l’atteggiamento di chi dice aprés moi la déluge – o meglio, nell’era dei Big Three, aprés nous la déluge – tutt’altro: è profondamente interessato ai tennisti della nuova generazione, e non solo perché deve ancora affrontarli. È sinceramente curioso di vedere chi sarà il prossimo numero 1, chi vincerà un major dopo l’altro e porterà il tennis sempre più avanti e, si spera, non indietro. Verso la fine del pranzo, con le tazze da caffè ormai vuote sul tavolo, discutemmo su quale dei giovani avesse le caratteristiche giuste. «[Alexander] Zverev, forse? [Stefanos] Tsitsipas?» chiese, in un tono più curioso che convinto. Facemmo i nomi anche di diversi altri tennisti. «Sai com’è, il gioco produce superstar in continuazione, per cui non me ne preoccupo», osservò. «Forse quando l’attuale generazione si sarà esaurita si sentiranno più liberi e si sbloccherà tutto il loro potenziale. Forse devono vincere un torneo importante per crederci. A me è servito. Ho dovuto vincere Wimbledon per dire: “Ok, posso farcela tutte le settimane”. Forse hanno bisogno di questo, perché per il momento non possono dire: “Voglio essere il numero uno del mondo”, altrimenti tutti risponderanno: “Ah! Il numero uno è Novak”, oppure: “Sì, ma come farai a battere Rafa?”».