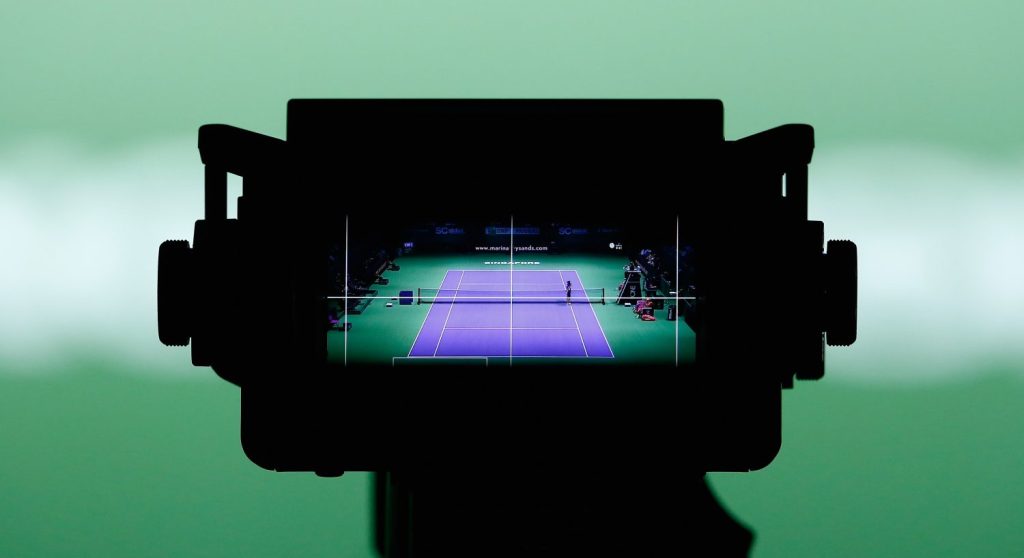Nelle fotografie di quei giorni, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, l’Australia sembra l’inferno in terra. Dal cielo si spande una luce rossiccia come nei film di Villeneuve, a terra scorrono rivoli di fuoco che sembrano elettrici, gli alberi sono torce di fiamme. In qualche foto c’è un animale, un canguro, dei cavalli, che scappano od osservano la fine dei tempi. Quando le fiamme si esauriscono scoprono la morte del mondo naturale: gli alberi sono tizzoni di cenere, sopra un manto nero da cui si alza una nebbia mefitica. I fumi si disperdono nell’aria perdendo la loro dimensione visibile, attraversando grandi spazi sotto forma gassosa.
Negli stessi giorni, a gennaio, si stanno giocando i match di qualificazione all’Australian Open e in campo c’è Dalila Jakupovic, in passato tra le prime settanta tenniste al mondo. Mentre serve nel secondo set, sente però che qualcosa non va. Mentre restituisce due palline alla raccattapalle, si stropiccia gli occhi e quando li mette a favore di telecamera sono bagnati e dolenti; digrigna la bocca in una smorfia tormentata, poi si inginocchia e si porta una mano alla bocca. È uno degli esseri umani più in forma del pianeta, ma in quel momento non riesce né a camminare né a respirare. Rimette dentro un asciugamano chinata a terra, poi la rialzano a forza, le mettono al collo un asciugamano di ghiaccio e la scortano fuori dal campo. Le polveri tossiche degli incendi hanno infestato Melbourne e la qualità dell’aria quel giorno è la peggiore al mondo: l’amministrazione cittadina ha invitato le persone a non uscire di casa, giocare una partita di tennis è semplicemente da sconsiderati, ma Dalila Jakupovic era in campo. «In tutta la partita per me è stato difficile respirare, avevo la sensazione di poter collassare in campo da un momento all’altro», ha detto Jakupovic il giorno dopo.
Quelle giornate di Australian Open sono ricche di immagini angoscianti: raccattapalle svenuti, ritiri, Bernard Tomic che respira da un inalatore durante un cambio campo, alla disperata ricerca di aria pulita. Nei notiziari si susseguono le immagini di incendi infernali, vegetazione bruciata: ecosistemi rovinati, miliardi di esemplari animali uccisi, un patrimonio naturale perso per sempre. The Age titola in quei giorni: «Negare il cambiamento climatico è una perdita di tempo». Queste scene da distonia climatica non sono rare quando si gioca l’Australian Open: su nessun altro evento sportivo gli effetti della crisi sono tanto evidenti, messi davanti ai nostri occhi attraverso i corpi sofferenti dei giocatori, le loro maglie bagnate di lavatrice, gli occhi sconvolti. Per ragioni di calendario, per partite che si giocano tradizionalmente negli orari più caldi delle stagioni più calde, il tennis si è sempre giocato in condizioni di caldo estreme.
I tornei della stagione americana sul cemento sono una grande esibizione di sopravvivenza del più forte, ed esiste uno strano dibattito se sia più caldo lo US Open o l’Australian Open. A New York il tasso di umidità rende impossibile smaltire il sudore, è come se qualcuno ti innaffiasse dall’interno; a Melbourne però è la terra che scotta, le suole delle scarpe sfrigolano, secondo Andre Agassi: «È come giocare dentro un forno gigante». La situazione è migliorata da quando, nel 2008, è stata cambiata la superficie, dal Rebound Ace al Plexicushion, che assorbe meno calore. Il vecchio manto di cemento era una spugna, al punto che presentava una differenza di velocità sensibile nel rimbalzo all’ombra o in quello al sole. L’altro aspetto che rende l’Australian Open più sensibile rispetto allo slam statunitense, è che i giocatori ci arrivano con meno preparazione, al termine della lunga sostanza natalizia, mentre al corpo servirebbero almeno dieci giorni di allenamenti per acclimatarsi alle alte temperature. Per abituare il ritmo cardiaco, o per sudare di più, e attivare quindi i processi di raffreddamento dell’organismo.
Nel 1997, per la prima volta, l’organizzazione del torneo ha scelto di chiudere il tetto dello stadio centrale non per la pioggia ma per il caldo. Quell’anno le temperature erano così alte che secondo alcuni giocatori potevi sentire «bollire i calzini». Il tetto è stato chiuso per ragioni di sicurezza, dei giocatori e degli spettatori. Dall’anno successivo Tennis Australia ha quindi dotato il torneo di una policy sul clima estremo: è stato il primo evento sportivo al mondo ad averne una. In sostanza stiamo parlando di linee guida che gli arbitri devono seguire per capire quando è troppo caldo per giocare a tennis, o quando devono estendere gli intervalli di gioco. In quei momenti i tennisti possono riposare i loro corpi sulle sedie, blocchi di ghiaccio vengono poggiati sulle loro schiene incandescenti come per provare a raffreddare un motore surriscaldato. I più esperti avvolgono gli asciugamani di ghiaccio sul collo per sfiammare. I giocatori restano fermi con gli occhi acquosi persi in un punto indefinito, bonzi alla ricerca della perfetta immobilità, delle condizioni ideali per far scendere la temperatura corporea. «Immagino di essere sulla spiaggia con un margarita in mano, la vita è bella», ha scherzato Caroline Wozniacki.
Il 2014 è stato un anno critico: l’unico in cui ci sono stati quattro giorni consecutivi di temperature sopra i quaranta gradi. Novak Djokovic ha fatto friggere un uovo sul cemento a scopi dimostrativi. Durante un match il tennista canadese Frank Dancevic ha vissuto un’esperienza paranormale: «A metà del primo set mi sentivo confuso, poi ho visto Snoopy e ho pensato “Wow, Snoopy, strano”». Quattro anni dopo, nel 2018, Alizé Cornet è collassata in campo. Mentre serviva nel terzo set, in un cocente venerdì pomeriggio, non ce l’ha fatta più e si è accasciata in un angolo d’ombra con le mani sulla testa; aveva provato a resistere a forza di ghiaccio, acqua spray, ventilatori, ma ha dovuto arrendersi. Nella stessa edizione, una sfida tra Djokovic e Monfils è diventata una lotta per la sopravvivenza in senso molto poco metaforico. Gael Monfils, dopo essersi ritirato, ha detto di aver giocato con addosso un senso di morte per una quarantina di minuti; poi ha augurato buona fortuna ai tennisti ancora nel tabellone, chiedendogli di non fare gli eroi e di ritirarsi se non si sentono più in grado di giocare. Non meno preoccupati i toni di Djokovic: «C’è un limite, un confine tra essere in forma ed essere in pericolo in termini i salute. Oggi eravamo quasi oltre il limite». In quanti sport si arriva a parlare così esplicitamente di morte? Negli ultimi anni di innalzamento delle temperature globali è diventato inevitabile, i tennisti in campo si sentono davvero vicini a un limite spaventoso.

Il caldo torrido e l’umidità dell’estate australe sono dei grandi problemi per gli Australian Open. Dal 1988, anno dell’installazione del tetto retrattile alla Rod Laver Arena, sono stati predisposti dei protocolli per evitare problemi a tennisti e tifosi; nel 2019 è stata introdotta una scala di stress termico per determinare se le condizioni sono abbastanza sicure per giocatori e pubblico (Mark Metcalfe/Getty Images)
«Se morirò oggi su questo campo di chi sarà la responsabilità?», ha detto con fatalismo esistenziale Daniil Medvedev quest’estate a Tokyo; Ivan Dodig a Melbourne ha ammesso di essersi ritrovato a chiedersi se, dietro le sembianze ordinarie di una partita, non stesse rischiando la vita. Lo sport degli ultimi anni, e in particolare il tennis, ama celebrare la resistenza gladiatoria degli atleti, capaci di esprimere il loro talento anche nei contesti più compromessi, ma il clima all’Australian Open spesso ha superato un confine, facendoci entrare in un territorio in cui non sappiamo più cosa stiamo guardando. È ancora tennis quello che si gioca in condizioni tanto proibitive o diventa solo una gara di stoicismo? Cosa c’è di bello nel vedere uno dei più grandi atleti di sempre, Novak Djokovic, squagliarsi nel caldo impossibile? Quanto è eticamente sostenibile che la sofferenza fisica di un essere umano possa diventare uno spettacolo? Tennis Australia ha avuto anni fa anche momenti di negazionismo comico, come quando nel 2014 il medico del torneo, Tim Wood, affermava che le condizioni di gioco erano sicure per ragioni evoluzionistiche: «L’uomo si è adattato a fare esercizio nel caldo. Qualche migliaia di anno fa ci siamo evoluti sugli altipiani dell’Africa rincorrendo antilopi per otto ore nel caldo estremo». A parte questa sparata, però, l’Australian Open prende seriamente il caldo. Il clima viene monitorato costantemente, tenendo conto di vari fattori: temperatura, umidità, radiazioni e velocità del vento; il tutto viene poi parametrato su una scala da uno a cinque. È un modello sviluppato in collaborazione con l’università di Sidney, e che tiene informati pubblico e giocatori in tempo reale. Se l’indicatore arriva a 3, i tennisti vengono invitati a idratarsi di più e a cercare refrigerazione; a 4 l’arbitro può prolungare gli intervalli tra un set e l’altro; a 5 la partita viene sospesa.
Nella crisi climatica che sta attraversando il pianeta, l’Australian Open rappresenta un evento di frontiera. La temperatura del Paese nell’ultimo secolo è salita di un grado, e insieme si sono moltiplicati i fenomeni climatici estremi come tornado, incendi, piogge feroci, inondazioni. Nel rapporto Love 40 degrees, commissionato dall’Australian Conservation Foundation, vengono esaminati gli effetti che il cambiamento climatico sta producendo sull’Australian Open. Nel documento si cita anche lo studio del Climate Change Performance Index, che indica l’Australia come il Paese col clima peggiore tra i 57 analizzati. La situazione è così grave che si sta ragionando sulla possibilità di spostare il torneo da gennaio a mesi più clementi, come novembre o marzo. Una misura che congestionerebbe ulteriormente una stagione tennistica già insostenibile. E cosa succederebbe se anche gli US Open, e la stagione nordamericana in generale, fossero costretti a trovare una collocazione più mite nel calendario? Un’altra soluzione sarebbe quella di prolungare la durata complessiva del torneo, così da permettere una programmazione che eviti gli orari più pericolosi.
Lo sport sta già re-immaginando sé stesso in un mondo con condizioni climatiche sempre più ostili, a cominciare dall’evento più importante, i Mondiali di calcio. Nel 2014 si è corso il rischio di giocare nel clima tropicale di Manaus, in uno stadio conficcato nel cuore della foresta amazzonica. I calciatori esausti si sono dovuti fermare durante la partita per un minuto di idratazione, il cooling break: una pratica che ora diamo per scontata ma di cui all’epoca non sembrava esserci necessità. I Mondiali del 2022 sono in programma in Qatar, dove in estate la temperatura può raggiungere i cinquanta gradi, e si è quindi deciso, per la prima volta nella storia, di spostare i campionati del mondo a gennaio, nei mesi invernali – lasciando che fossero gli operai impegnati nella costruzioni degli impianti e delle infrastrutture a lasciarci la pelle, sotto il sole del Golfo Persico. Tra qualche anno ricorderemo i Mondiali estivi come un’abitudine appartenente a un mondo ormai perduto?
In questi anni i corpi dolenti dei tennisti a Melbourne hanno offerto una consistenza visibile a una dimensione – quella della crisi ambientale – che rimane spesso occulta. Esseri umani al massimo della forma che collassano durante eventi sportivi d’élite sono fotografie della catastrofe come altre con cui stiamo familiarizzando: i ghiacciai che si sciolgono, le foreste incenerite, i sacchi di sabbia adagiati sulle coste di Tuvalu, uno degli arcipelaghi di isole che prima dovrebbe essere inghiottito dal mare, dove il suo ministro ha parlato alla Cop26 con l’acqua fin sopra le ginocchia mentre diceva «Stiamo affondando». Immagini che aiutano a costruire un racconto riconoscibile sulla crisi climatica, a fornire una dimensione concreta all’inimmaginabile di cui parla Amitav Gosh ne La Grande Cecità.
In questo scenario, l’Australian Open rappresenta uno dei laboratori in cui è più interessante sperimentare come sarà lo sport del futuro, che forma dovrà prendere per sopravvivere ai tempi del disastro climatico. Il tennis del resto è uno degli sport maggiormente condizionati dai fattori ambientali, e la sua stagione è tradizionalmente strutturata attorno all’alternanza delle superfici e delle stagioni, seguendo un ciclo che abbiamo imparato a considerare naturale. Una natura che, vista con gli occhi di oggi, ci appare incredibilmente novecentesca.