«Ha segnato di nuovo l’amico tuo», dice ridendo mio nonno. È il 15 aprile 1998 e ho 10 anni. Alessandro Del Piero, invece, di anni ne ha 23 e in quella primavera sta contendendo a Ronaldo il Fenomeno il titolo di giocatore più forte del mondo. Il gol che ha appena realizzato al Monaco nel ritorno della semifinale di Champions League, il trentaduesimo di una stagione leggendaria, spiega perfettamente il perché. Il cross dalla destra di Moreno Torricelli è alto, lento, prevedibile, il pallone peggiore possibile che un attaccante debba trovarsi a gestire all’interno dell’area di rigore. Del Piero, che stava accennando al movimento per attaccare il secondo palo, non si scompone: si ferma, segue con lo sguardo l’evoluzione della traiettoria mentre calcola mentalmente i passi all’indietro che gli saranno necessari per ricoordinarsi, pianta la gamba sinistra per utilizzarla come perno e calcia al volo di destro, di collo pieno e in semi-rovesciata, utilizzando la forza dell’effetto fionda generato dalla torsione del tronco e degli addominali per inchiodare Fabien Barthez.
Quel Del Piero è il motivo per cui tanti ragazzi della mia generazione sono diventati tifosi juventini. Così come Platini, Baggio, Zidane, Nedved, Tévez, Pogba, Dybala lo sono stati per le generazioni precedenti e successive. Eppure credo che in quella frase che mi disse mio nonno, napoletano e tifoso del Napoli, si nasconda il senso più profondo di tifare una squadra che non è geograficamente la tua, anche quando l’infatuazione per il singolo calciatore si trasforma in un sentimento più maturo e consapevole. Se si dice che gli amici sono la famiglia che ci si sceglie, allora una squadra lontana da te può instillare quel senso di comunanza, appartenenza e identità che non è stato trasmesso in via ereditaria. Nonno se ne andò tre anni dopo e non ha vissuto il mio passaggio all’età adulta da tifoso, quindi non so dire se il mio essere diventato juventino lo avrebbe intristito, deluso o addirittura offeso. L’unico riferimento che mi è rimasto è mio padre, che mi ha educato all’accettazione del rapporto che c’è tra decisioni e conseguenze e al rispetto che si deve portare alle scelte che si fanno; per lui non è mai stato un problema che io tifassi Juve ma quella scelta avrei dovuto imparare a spiegarla e difenderla, accettando la possibilità di non essere compreso fino in fondo.
All’inizio fu semplice, come sempre quando si è ragazzini. A scuola, in palestra, al campetto, il tifo era libero, slegato dall’idea di rivalsa e riscatto sociale, una splendida madeleine dell’epoca d’oro della Serie A delle Sette Sorelle, quando era normale che anche a Napoli e al Sud in generale le squadre preferite fossero la Juventus, le milanesi, le romane, il Parma, la Fiorentina. Tanti di quelli con cui sono cresciuto, poi, hanno maturato una consapevolezza diversa, rivendicando il diritto-dovere a un tifo più aderente al vincolo feroce della territorialità. Non li ho mai giudicati perché sono scelte, appunto. Però mi ha sempre fatto pensare che quelli che non avessero mai cambiato idea fossero proprio gli juventini, come se quel legame infantile avesse trovato un modo tutto suo per resistere al tempo, alle distanze, ai condizionamenti, all’umano desiderio di sentirsi parte di un gruppo a costo di sacrificare una parte di sé, nell’Italia dei mille campanili e delle rivalità che sorgono nello spazio di pochi chilometri. Non poteva dipendere unicamente dalla frequenza e dal numero delle vittorie, perché il tifoso per natura tende a pensare in negativo, a ricordare di più i momenti in cui ha pianto per una sconfitta in finale rispetto a quelli in cui ha gioito per uno scudetto o un trofeo, in una ciclica ripetitività degli eventi.


Secondo i dati ufficiali forniti dalla Juventus, i fan club ufficiali sparsi in tutta Italia sono 422. Se guardiamo al resto del mondo, diventano più di 550. Ovviamente si tratta della cifra più alta in assoluto per un club del nostro Paese.
La Juventus è forse l’unica realtà italiana davvero trasversale, la squadra nazionalpopolare per eccellenza, quella che consente di mettere nella stessa frase Palmiro Togliatti (che a Pietro Secchia disse «non si può fare la rivoluzione senza conoscere il risultato della Juve») e Tommaso Buscetta («Essere juventino è una delle cose di cui non dovrà pentirsi», spiegò Gianni Agnelli a Enzo Biagi). È il punto d’incontro tra le diverse anime di un Paese tradizionalista e conservatore che al peso delle tradizioni e all’osservanza delle liturgie laiche ha legato la sua riconoscibilità nel resto del mondo. «Io credo che già il nome contribuisca a far sì che la Juventus non venga identificata come una semplice estensione di Torino. La Juventus è una squadra italiana, anzi è una questione italiana», mi spiega Luigi Palumbo, presidente dello Juventus Club Cercola in provincia di Napoli, sesto fan club ufficiale al mondo per numero di iscritti, nato nel 2002 in «uno dei luoghi dove tifare Juve è molto più difficile che altrove».
Oggi in Italia ci sono 422 Juventus club ufficiali, 167 al Sud, 100 solo tra Campania, Calabria e Sicilia. Una presenza sul territorio talmente radicata da far immaginare che il numero dei tifosi bianconeri sia così elevato da poter mettere in discussione il primato locale anche in piazze importanti e storiche come Bari, Napoli, Lecce, Palermo, Catania, Cagliari. Negli anni molti hanno voluto raccontare questo fenomeno come un’appendice della questione meridionale, come se i tifosi della Juventus fossero l’equivalente di chi è costretto a emigrare al Nord in cerca di fortuna ma con la differenza che, almeno nel calcio, qualcosa per cui varrebbe la pena restare ci sarebbe eccome. L’aver venduto l’anima alla “squadra del padrone” rinnegando le proprie origini viene vista come una colpa ancor più grave, la scorciatoia presa da chi non ha avuto il coraggio di restare a combattere per un ideale superiore: «La Juventus viene sempre vista come la squadra favorita o, comunque, quella cui non vanno mai riconosciuti i meriti pure quando sono evidenti. Eppure più aumentano gli attacchi e le insinuazioni, più il mio legame con questa squadra si rafforza, più sono convinto della mia scelta di volerle bene. È una lotta ma se si resta nelle logiche dello sport, senza dover per forza odiare o tifare contro qualcuno, non c’è nulla di male nel tifare una squadra che non è quella della propria città», continua Palumbo.

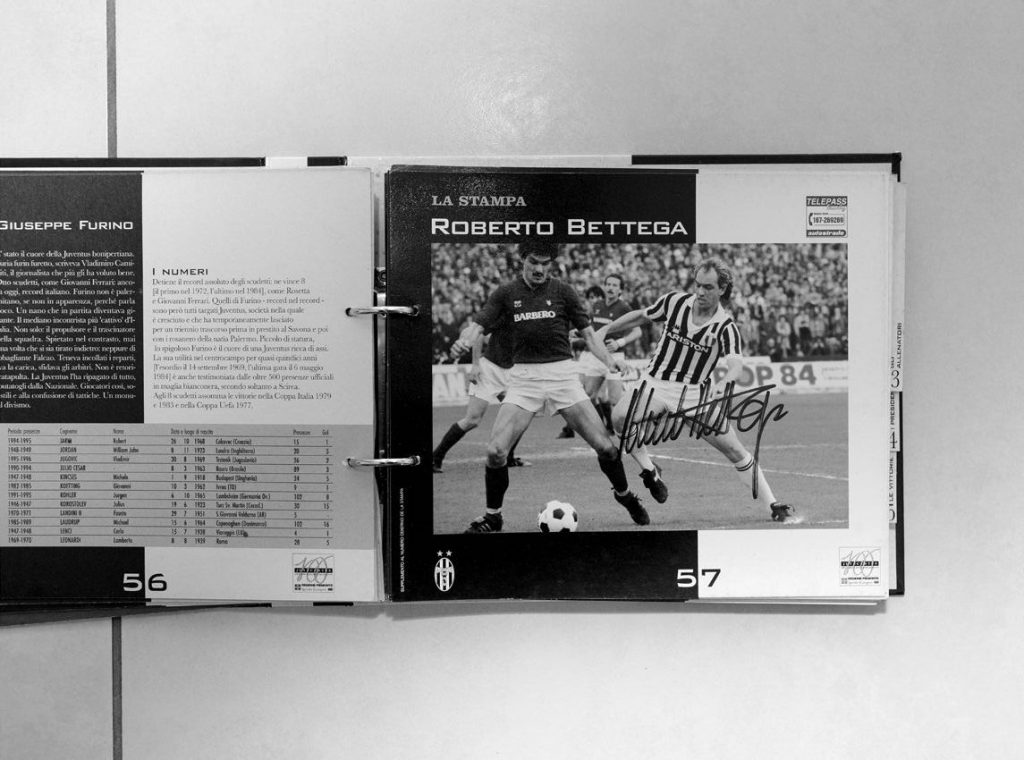
Sono i fan club Juve disseminati nelle varie regioni del Sud Italia. Di questi, 50 si trovano in Sicilia: è il numero più alto in assoluto, nel senso che nessuna regione italiana ne ha di più. In Piemonte, per dire, ce ne sono 31.
Sarebbe perciò sbagliato pensare a una scelta di comodo o a una passione anestetizzata dall’assenza di connessioni territoriali. Il tifo juventino presenta una connotazione identitaria diversa ma altrettanto forte e che ha anticipato di oltre mezzo secolo quell’idea di fanbase globalizzata che spinge i principali club del mondo a cercare nuovi modi per fidelizzare tifosi e appassionati. Fin dagli anni Cinquanta e Sessanta tifare Juve è stato, per molti, un modo come un altro per non sentirsi esclusi dalle tensioni sociali e culturali di un Paese che stava cambiando; e la Juve stessa è poi diventata l’unica risposta possibile alla sempre crescente domanda di grande calcio in luoghi dove quest’ultimo faticava ad arrivare o era persino assente anche nella dimensione localistica.
Ed è proprio qui che la Juventus è diventata una squadra popolare nel senso letterale del termine, quella questione “di padre in figlio” che sembrava non appartenerle e che ha invece generato il paradosso per cui la comunità e il senso di appartenenza si sono sviluppati pure in quei territori dove non avrebbero potuto esistere: «Qui in Puglia la mancanza di un grande club ha favorito il radicamento del tifo bianconero. Ci si potrebbe poi chiedere perché proprio la Juve rispetto al Milan o all’Inter, ma credo che dipenda da una componente generazionale: quando sono nati i moderni servizi di fruizione televisiva del calcio si era in piena epopea lippiana, mentre oggi ci sono ragazzi che sono appena usciti dal ciclo dei nove scudetti consecutivi», mi conferma Paolo Romano, referente della comunicazione dello Juve Club “Andrea Agnelli” di Brindisi. C’è poi da considerare quanto e come la Juventus incarni una certa visione del tifo: «Tifare Juve vuol dire far parte di una storia vincente ma non comoda, essere membri di una comunità che unisce e divide allo stesso tempo e che è in guerra con tutti. È una sensazione inebriante perché risponde a impulsi semplici e scarnificati, se vogliamo primordiali e manichei, contrapposti alla prudente moderazione razionale. La Juve è riscatto e reazione qui al Sud. È il club di proprietà dei potenti requisito dal popolo».
Per questo il ruolo dei club è fondamentale, soprattutto nell’epoca in cui il calcio è diventato una forma di intrattenimento che non necessita di uno spazio condiviso per poter essere fruito. Creare dei momenti di aggregazione slegati dall’evento partita è più importante della partita stessa e del suo esito, nel ribaltamento delle prospettive che si verifica ogni volta che il mezzo si trasforma nel fine ultimo di un gruppo di persone che ha bisogno di riconoscersi, ritrovarsi, stare insieme. E gli interminabili viaggi in pullman in direzione Stadium con partenza all’alba e rientro a notte fonda – ricordati anche da Cristiano Giuntoli nei giorni del suo insediamento alla Continassa – rappresentano il ponte tra passato, presente e futuro, il filo rosso che unisce due o tre generazioni che non avrebbero altrimenti un linguaggio in comune, l’attimo in cui la tradizione si fa innovazione senza perdere la sacralità di uno dei tanti riti che si ripetono sempre uguali fino a diventare casa, famiglia, comunità. Il senso di tifare Juve, al Sud e altrove, è tutto qui, è nel sorriso sul volto di uno degli eterni ragazzi del club Cercola quando, al momento dei saluti, mi dice «noi siamo la Juventus». E come direbbe il Paul Ashworth di Fever Pitch: «Che male c’è in questo?».





