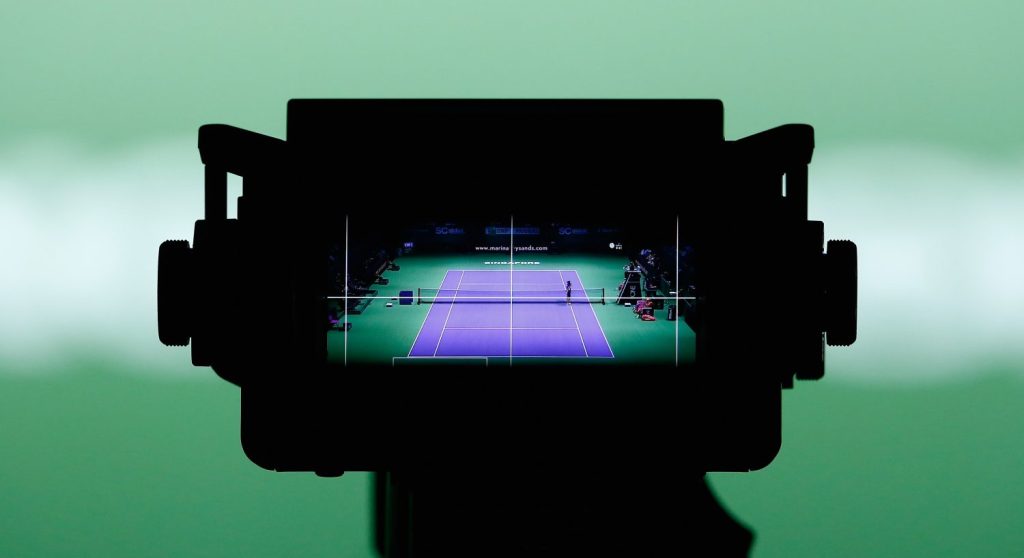Vincenzo Santopadre risponde alla videochiamata ancora chiuso dentro l’auto, gli ultimi raggi di sole della giornata gli illuminano a tratti il viso. È in un parcheggio nella città di Roma, dov’è nato. E dove ha scoperto la passione per il tennis, all’età di otto anni, nel circolo che frequentava insieme ai genitori e alle due sorelle più grandi, il Sant’Agnese Tennis Club. Alcuni anni dopo, gli allenamenti sono diventati cinque alla settimana, al Parioli di Roma. Ha vinto i primi titoli italiani junior individuali e a squadre, prima di entrare tra i pro nel 1991. Ha vinto cinque titoli a livello Challenger in singolare e non dimenticherà mai le due vittorie agli Internazionali d’Italia: la prima contro l’ex numero 10 del mondo Karol Kucera (1998), la seconda contro il campione uscente Magnus Norman (2001). Santopadre ha giocato un solo match di singolare in un torneo dello Slam nel 1999, a Wimbledon, perdendo in quattro set, tutti finiti al tiebreak, dall’australiano Wayne Arthurs.
Sorride mentre ripercorriamo la sua carriera da tennista, legata ad allenatori che hanno lasciato il segno nel passato e che ancora oggi contribuiscono a migliorare il suo presente. Sorride ancora pensando a quello che è successo quando ha smesso di giocare: 13 anni passati al fianco di Matteo Berrettini, un ragazzino nato a Roma. Proprio come lui. Insieme a Santopadre, Berrettini è diventato uomo, campione, uno dei tennisti italiani più forte dei nostri tempi. Ha vinto sette titoli in singolare, è stato finalista a Wimbledon ed è diventato il numero 6 del mondo.
In quegli anni, Santopadre è stato anche nominato capitano dalla squadra dell’ATP Cup, composta da Simone Bolelli, Fabio Fognini, Andrea Vavassori e Matteo Berrettini. Nella prima edizione della United Cup, la competizione a squadre mista tra uomini e donne, è stato scelto ancora una volta come capitano degli azzurri. Nel 2019, quasi trent’anni dopo essere entrato nel mondo dei professionisti come giocatore, è stato nominato nella cinquina dei migliori allenatori dell’anno. Dopo una vita trascorsa in un team che poteva chiamare quasi famiglia, la settimana scorsa, ha iniziato una nuova avventura da allenatore nella squadra di Luca Van Assche, un tennista francese di 19 anni, numero 68 del mondo.
Ⓤ: Partiamo dall’inizio. Quando hai capito di voler diventare il coach di un professionista? E quanto ha influito in questa scelta il fatto di aver conosciuto Matteo Berrettini, che all’epoca era solo un ragazzino?
Credo che abbia influito in maniera assolutamente determinante. Quando ho smesso di giocare però, mi è venuto naturale buttarmi nell’insegnamento, mi è sempre piaciuto a prescindere. Poi è capitato che con Matteo, facendo le cose in un certo modo, le sue esigenze siano cambiate e di conseguenza è cambiato anche il mio modo di insegnare. È stato un po’ come un insegnante che parte da un bambino dell’asilo e continua a seguirlo anche alle elementari, poi al liceo e alla fine deve continuare a formarlo anche all’università. Questo è quello che mi è capitato con Matteo e, per riuscire a farcela, ho imparato strada facendo. Nessuno è nato imparato in nessun mestiere. A prescindere da questa storia però, a me piace stare in campo con qualsiasi appassionato di questo sport. Che sia un professionista, un avvocato o un ragazzino. Poi ovviamente bisogna plasmarsi con chi hai davanti e cambiare a seconda delle esigenze.
Ⓤ: Il tennis è uno sport individuale, anche se per moltissimi aspetti è uno sport di squadra. Però i tennisti si abituano al ruolo di protagonista nella storia. Nella tua esperienza personale, è stato difficile passare dal ruolo di protagonista al ruolo diciamo di attore “non protagonista”?
No per me non lo è stato, non ho avuto problemi. Bisogna fare dei passi indietro per formare dei giocatori con una personalità importante. Perché è giusto che siano loro i protagonisti. L’allenatore deve saper stare dietro le quinte. Non voglio essere in alcun modo presuntuoso ma penso di saper stare sia sulla scena che dietro la scena. Non ho nessuna volontà di apparire perché più passa il tempo e più mi accorgo che tanto non sapevo nulla neanche prima, e bisogna sempre continuare a imparare.
Ⓤ: Sei molto legato a Giampaolo Coppo, il tuo ex allenatore con una laurea in Filosofia e Psicologia. Oltre ad averti allenato, è stato una figura che ti ha insegnato qualcosa in particolare per essere un bravo allenatore? Ci sono altre persone che ti vengono in mente?
Ho avuto la fortuna di riuscire a stare in campo con delle persone che mi hanno formato sia come giocatore che come allenatore. Giampaolo Coppo è stato mio allenatore anche quando giocavo ma collaboriamo tutt’ora. Ed è un fenomeno dal punto di vista mentale. Lui riusciva ad allenarmi con una comunicazione molto particolare, basata sull’ascolto, molto difficile oggi da trovare. Ma la qualità più grande di Coppo, che ho cercato di imparare, è come tenersi sempre fuori dal giudizio. Poi ho avuto la fortuna di essere allenato da Paolo Spezzi, con il quale ho collaborato anche in Accademia a Roma, un’avventura se vogliamo più imprenditoriale nella quale ci siamo lanciati insieme. Spezzi è stato eccezionale nel trasmettermi la parte tattica. Con Vittorio Magnelli invece, ho imparato la dedizione al lavoro, l’attenzione, la presenza in campo. E poi c’è stato Chicco Meneschincheri. Sono stato davvero molto fortunato ad avere incontrato questi quattro allenatori con i quali continuo a collaborare. Mi piace condividere sempre tante idee per confrontarmi con loro. Ma non potrei mai dimenticare anche Panatta, Bertolucci e Barazzutti, come capitani della Davis, mi hanno arricchito moltissimo.
Ⓤ: Ho letto che per te ci devono essere due valori fondamentali, la pazienza e l’educazione, senza i quali il talento è difficile che basti per andare lontano. Trovi che sia difficile fare aderire questi due aspetti mentali del tennis alla parte più fisica e tecnica del tennista?
Oggi è diventato più difficile di una volta, ma è importante ricordarsi che è l’allenatore a dover avere quelle qualità in primis. È facile allenare un ragazzo che ha la mentalità già pronta, che ascolta e si comporta alla perfezione. Ma il vero capolavoro è riuscire a incidere su chi, quelle qualità, ancora non le conosce. Il successo è riuscire a far crescere il giocatore anche sotto quell’aspetto. Bisogna prestare molta attenzione a un fattore chiave: nel rapporto maestro-allievo, si cresce insieme.

Berrettini e Santopadre hanno collaborato fino alla fine del 2023. Con Santopadre al suo angolo, il tennista italiano ha vinto sette titoli ATP ed è diventato il primo italiano della storia a disputare la finale di Wimbledon, nel 2021 (Bradley Kanaris/Getty Images)
Ⓤ: Spesso vedo dei ragazzi che provano a entrare nel mondo dei professionisti ma, dopo qualche sconfitta in giro per l’Europa, tornano sconfortati e senza stimoli. Dev’essere molta dura per un allenatore continuare a stimolarli. Per te qual è l’aspetto più difficile nel tuo lavoro?
Non vedo aspetti duri in questo lavoro. Credo che l’allenatore debba essere il primo ad accettare che i ragazzi hanno delle difficoltà e che dietro il loro comportamento si celano quelle difficoltà. Bisogna riuscire a far parlare i ragazzi, a farli comunicare il più possibile perché devono capire che cos’hanno dentro e imparare a conoscersi. Credo che un ragazzo giovane non vada stimolato più di tanto perché l’importante è che lo stimolo ce l’abbia lui. Se i ragazzi non ce l’hanno o se cercano troppo lo stimolo nell’allenatore, allora forse dovrebbero cambiare sport.
Ⓤ: Hai lavorato molto con Stefano Massari per aiutare Berrettini a crescere dal punto di vista mentale. Credi che, per quanto un coach possa essere bravo e disponibile, ci sia bisogno di qualcuno che segue solo ed esclusivamente quella parte?
Abbiamo lavorato molto bene insieme. Stefano è una persona veramente piacevole, oltre ad essere un grande professionista. Credo però che non sia necessario, forse direi più che sia utile. Nadal ne è la dimostrazione, non ha un mental coach. La figura fondamentale, primaria, è il competente dell’area del campo. Poi siamo arrivati a capire che c’è una componente mentale che l’allenatore deve conoscere molto bene. Perché non possiamo trattarci tutti allo stesso modo, bisogna per forza creare un’empatia. L’allenatore deve distaccarsi da sé stesso ed entrare nella mente e nel cuore dell’atleta. Avendo avuto la fortuna di lavorare con Stefano ho dato seguito a questo valore molto importante. Ma non è detto che tutti quanti debbano per forza avere un mental coach.
Ⓤ: Tra i tanti traguardi raggiunti con Matteo, qual è stato quello più gratificante per te?
Dopo aver vissuto quello che è successo con Sinner, in Coppa Davis e in Australia, mi sono reso conto che c’è stato un paese completamente in fermento. Quando Matteo è arrivato in finale a Wimbledon, nonostante mi dicessero tutti che in Italia c’era già una forte eccitazione all’epoca, non l’avevo realizzato davvero. Anche quando siamo andati dal Presidente Mattarella, se ci ripenso adesso, è stato un momento incredibile del quale mi rendo più conto adesso. Ma tra i tanti bei momenti, quello che ricordo con grande gioia è stato il lunedì in cui Matteo è entrato in top 10. Ero a Parigi, stavamo tornando da Vienna con Matteo. Insieme al suo osteopata e con l’ex manager di Matteo siamo andati in camera sua e gli abbiamo organizzato un festeggiamento a sorpresa. Quello è stato davvero un bel momento per noi.
Ⓤ: Oltre a Stefano Massari, nel team di Berrettini eravate tutti molto uniti. Quasi come una seconda famiglia. Quanto è difficile adesso ripartire e adattarsi a un team completamente nuovo?
Il cambiamento dipende sempre dalla prospettiva in cui ti metti a guardarlo. Se guardo al passato sorrido perché è stato bellissimo. Però adesso c’è una nuova sfida stimolante che mi aspetta ed è bello vedere anche questo. Devo conoscere un altro ragazzo e con questo so che andrò ad arricchirmi a livello umano. Imparerò tanto anche grazie all’altro allenatore e a un altro mental coach che ho conosciuto a Rotterdam. I cambiamenti puoi viverli o in maniera timorosa o in modo stimolante, dipende dalla persona.
Ⓤ: Luca Van Assche è ancora molto giovane e ha già un’ottima classifica. Hai avuto modo di capire se sia uno che ha fretta di crescere o trovi che per il momento incarni bene il valore della pazienza?
È volenteroso di crescere, è un ragazzo molto determinato. Forse la mia unica paura è che quando scavalli quella determinazione, può diventare pericoloso per il processo di crescita. La volontà di migliorare non deve diventare frettolosa. Ma ad oggi sono fiducioso che troveremo l’equilibrio giusto perché avere tanta voglia di far bene è positivo. Mi sembra sul binario giusto.
Ⓤ: Tu sei stato il primo capitano della squadra azzurra nella United Cup, arrivata in finale contro gli Stati Uniti. Com’è stato gestire una squadra composta per la prima volta non solo da uomini ma anche da donne? Quali differenze hai notato rispetto alle tue esperienze in ATP Cup?
Si, ho notato delle differenze ma positive. Secondo me aiuta molto la squadra quando gli uomini e le donne devono stare insieme, per entrambe le parti. Il mio compito non è stato difficile da un punto di vista di scelte tecniche, a parte i doppi. L’incarico più difficile è stato trovare la chiave in ognuno di loro per cercare di fare squadra tutti insieme, anche con i membri del team dei rispettivi componenti. È stata un’avventura stupenda, per i ricordi e per i legami che sono rimasti. Al di là dei risultati.
Ⓤ: Sei stato il numero 100 del mondo e diversi anni dopo, nel 2019, sei stato nominato tra i cinque candidati come miglior coach dell’anno. Tu ti senti più un allenatore di successo o un giocatore di successo?
Mi sento una persona che sta bene, sono contento e mi sento felice. Da giocatore ho ottenuto qualche buon risultato, ma come allenatore ho ottenuto più risultati. Mi piace quello che faccio, che sia una semifinale, una finale o un primo turno incide in maniera relativa. Ho imparato a vincere e ho imparato a perdere. Naturalmente, sono più felice quando si vince ma non perdo il sorriso quando si perde. La vittoria è un percorso.
Ⓤ: Quanto c’è del Santopadre tennista nel Santopadre allenatore?
Ho cercato di staccarmi molto dalla parte “tennista”. Non mi piace parlare di quella parte di vita con i giocatori perché non credo sia utile; quindi faccio molta attenzione e non mi pesa doverlo fare. Quando sento altri allenatori che parlano delle loro carriere con i ragazzi non mi fa impazzire. Poi dipende sempre in che modo uno decide di farlo. Se può essere utile per aiutare l’allievo a non sentirsi diverso, allora ha senso. Faccio un esempio: se un mio giocatore si sente strano perché quando vince è molto euforico, gli potrei raccontare che anche io ero euforico dopo una vittoria al Foro Italico. Ma se il mio giocatore si sente triste, nonostante abbia vinto, e non ha voglia di esultare non glielo racconterò perché rischierei di farlo sentire strano. Qualsiasi emozione è giusta e va accettata, siamo tutti diversi.